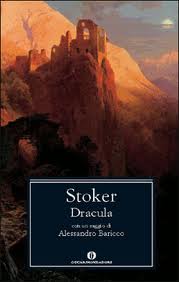- di Franco Tuscano
“I Perifània ton
palèon rìzomma!” – “ L’Orgoglio delle (nostre) antiche radici!”
“Nella parte più meridionale
della nostra penisola, in alcuni paesi montani che sorgono a metà strada fra
Locri e Reggio, gli anziani agricoltori ed i pastori parlano ancora un arcano
dialetto greco che, giunto fino a noi
attraverso una tradizione puramente orale, sembra quasi non aver mai
avuto un suo passato ed una sua storia ...”.
Così si esprimeva nella sua importante
opera: “La Glossa di Bova”, il compianto e mai dimenticato Prof. Giovanni Andrea
Crupi, il quale, in un’epoca “cruciale” (anni ’70) per la sopravvivenza
della Lingua Greca di Calabria,
antichissimo e nobilissimo “idioma dei Padri”, era riuscito, forse più di
chiunque altro, a porre la “questione grecanica” nei termini più “incisivi”
possibili. (Preciso fin da subito che, “grecanico” è un “etimo” – usato sia
come aggettivo che come sostantivo – che non amo, in quanto, nel tempo, ha
assunto una “connotazione” che, in parte, reputo impropria, una “deminutio”, e
la maggior parte dei “grecanici” non accettano questa definizione, preferendo
quella di: Grecofono, Ellenofono o Ellenofono di Calabria, Calabrogreco, Greco
di Calabria per indicare il parlante greco; ed ancora: lingua greca di
Calabria, Greco di Calabria, greco calabro o calabro greco per indicare il
proprio “dialetto”) – Vale a dire – tornando al Crupi –: non si trattava di
salvare soltanto una lingua (per altro lingua-madre…), ma tutta una cultura,
“le cui origini si perdevano nella notte dei tempi”. Egli lottò strenuamente
per dare voce ai “Greci di Calabria”: “Dòste mia fonì ecinò ti den tin èchu” –
Date una voce a quelli che non l’hanno”(citaz. del Prof. Filippo Violi), andava
ripetendo a tutti, compresi gli studenti di Liceo che, come il sottoscritto,
ebbero l’onore di averlo come Docente di Storia e Filosofia. “Greki ambrò!”, amava ribadire nei numerosi incontri e convegni a cui partecipava.
L’epigrafe in greco (in caratteri latini, com’è in uso nel Greco di Calabria),
sul freddo marmo della sua lapide, racchiude, in estrema sintesi, quelli che
sono stati i suoi valori
imprescindibili, ciò che ha rappresentato l’essenza della sua purtroppo breve esistenza:
Eplàtezza ‘zze filosofia,
“Ho parlato di filosofia”
Ègrazza stin glòssa tu Vua,
“Ho scritto nella lingua di Bova”
Agàpia tin anarchìa, “Ho amato l’anarchia”.
Ho voluto iniziare questo breve
lavoro “dando voce”, doverosamente, ad una delle più importanti figure del
“cosmo” greco-calabro, sia per la profonda stima da sempre nutrita nei suoi
confronti, sia perché, è stato proprio
in quegli anni (fine anni ’60, inizio anni ’70), che – grazie anche all’opera
del Crupi ed all’impegno di altri giovani valenti intellettuali della Bovesìa,
alcuni dei quali trasferitisi a Reggio, e con il contributo di qualche
importante studioso reggino – si è ricominciato a (ri)prendere coscienza del
proprio passato e si è sentito il bisogno di “recuperare”, di riscrivere la
propria storia, una storia che fin dalle sue lontanissime origini, trasuda di
una grecità profonda, granitica a tal punto da averne “ossificato” l’identità…
In questo “ultimo rifugio
dell’ellenismo” (leggi: Area Grecanica-Bovesìa), da ormai 30-40 anni, l’etnia
greca di Calabria è al centro di un intenso fermento intellettuale, avente come
obiettivo la salvaguardia, la rivalutazione e la valorizzazione del patrimonio
linguistico, storico e culturale dell’area.
Siamo “in finibus Calabriae”,
nell’estremità meridionale dell’Aspromonte, un territorio in cui, nel corso
della sua plurimillenaria storia, si è miracolosamente conservata un’identità
linguistico-culturale, rimasta per alcuni versi un “unicum” nel panorama della
Calabria intera. È questa l’area in cui vivono (continuano a vivere, fin…
dall’VIII sec. a.C.) i Greci di Calabria, “diventati” minoranza linguistica, ma
da sempre “maggioranza culturale”, dal momento che le radici, “I Rìze”, “valori
eterni”, permeano secoli e secoli di storia, facendo dell’estremo punto
meridionale della Calabria, una “terra dall’anima greca”, una “terra greca
nell’occidente latino”. Terra, storicamente più orientata verso la “Graecitas”
che la “Romànitas”, in cui è del tutto palese, tra l’altro, una
“interdipendenza culturale” con l’intera Calabria meridionale, ma, soprattutto,
con la Locride, con l’Area dello Stretto, con l’Estremità Nord-Orientale della
Sicilia e con la Grecìa Salentina.
In questo lavoro, concentreremo
la nostra attenzione, soprattutto, su quello che può essere considerato il
segmento culturale più importante (o, quanto meno, tra i più importanti) della
cultura greco-calabra, ovvero la lingua, “elemento” di vitale importanza per la
sopravvivenza del tanto variegato quanto affascinante mondo dei “Grèki tis Kalavrìa”.
Sul “greco di Calabria” o
“greco-bovese” (per dirla con il Crupi e con il Rohlfs), moltissimo è stato
scritto. Pertanto, questa breve nota non ha né può avere pretesa alcuna, di
aggiungere nulla di particolarmente “nuovo”, semmai, vuole semplicemente
essere, una pacata ma sentita “riflessione” sulla “glòssa palèa”, sulla lingua
dei Padri, per secoli in “travaglio”, in affanno, addirittura in agonia, ma mai
morta, nonostante innumerevoli “becchini”, nel corso della sua lunga storia, si
siano accostati più volte dinanzi al quasi “feretro greco-calabro”, con lo
scopo di poterlo “finalmente” seppellire…
L’origine della lingua greca di
Calabria, non è stata mai definitivamente chiarita, e l’acceso dibattito che
non ha lesinato “punte” di aspra polemica, tra lo schieramento “rohlfsiano”,
che ritiene il “greco di Calabria” diretto discendente di quello della Magna
Grecia, e quello “morosiano” (o, “parlangeliano”), che lo vuole invece erede
del greco-bizantino (nato, cioè, in età bizantina), ha portato ad una gran
quantità di studi, ma non ha – per alcuni – risolto del tutto, i dubbi sulla
sua “nascita”. La tesi “megaloellenica” (rohlfsiana), è comunque quella
nettamente dominante, e sono molti ad aver attribuito alla teoria
“bizantinista” ragioni di ordine “ideologico”.
Senza immergerci nell’aspetto
prettamente linguistico, solo “sfiorandolo” a mala pena, diciamo che Gerhard Rohlfs, ha più volte ricordato che i
Bizantini (in realtà: “Romèi”, ovvero, “Romani d’Oriente”, di cultura greca),
non hanno lasciato traccia alcuna della loro lingua né a Bari né a Ravenna (ex
Capitale dell’Esarcato) né in Dalmazia e neppure in Sardegna, regioni dove, a
lungo, mantennero il loro impero.
Se da una parte i “dorismi” e gli
“arcaismi”, anteriori alla “Koinè” (IV sec. a.C.), presenti esclusivamente nel “greco di Calabria”,
“tagliano la testa al toro” riguardo l’origine dell’idioma tutt’ora presente – per
lo più – nella “Isola Ellenofona
dell’Area Grecanica”, d’altra parte, sono gli stessi storici ad indicare
una realistica soluzione ella “vexata quaestio”. Vera Von Falkenausen, in
merito, dice: “Sembra che la grecità meridionale si basi su un sostrato greco
anteriore, che non si era mai completamente spento e che fu quindi “rianimato”
dalla “riconquista bizantina”. L’illustre studiosa, inoltre, esclude un
progetto “dall’alto”, da parte di Costantinopoli, che avrebbe comportato una
migrazione “pilotata” di popolazioni in grado di “colonizzare”, in senso
“greco”, la Calabria. Trasferimenti di gruppi etnicamente omogenei, erano
normali in un impero plurietnico come quello bizantino, per esigenze militari e
commerciali; ma ciò, “non può essere considerato come uno spostamento di
popolazioni numericamente rilevante”; (…)” possiamo calcolare che una flotta di
100 navi, avrebbe potuto trasferire al massimo 15.000 orientali in Italia, se
tutte le navi avessero raggiunto la destinazione senza danno”.
Inoltre, i bizantini non hanno
mai imposto la propria lingua ai propri sudditi, e, per di più, alla metà
dell'VIII sec., la Calabria era già di lingua e liturgia bizantina, tanto è
vero che il decreto di Leone III L’Isàurico(732-733), non incontrò nessuna
opposizione “in loco” (cosa che invece non si verificherà quando i Normanni
cominceranno a “latinizzare” la Calabria, imponendo la lingua latina e la liturgia di Roma).
Un ulteriore, significativo
contributo alla tesi “magnogreca” ci viene fornito, di recente, da una pregevolissima ed importantissima edizione di
62 epigrafi greche del Museo di Reggio Calabria, pubblicata dalla epigrafista
Lucia D’Amore nel 2007. Attraverso la loro attenta lettura, qualsiasi linguista
che non abbia posizioni precostituite, può agevolmente rendersi conto, infatti,
che la tesi di Rohlfs sulla presenza nella Calabria meridionale, di ellenofoni,
fin dai tempi antichi, è qui confermata “scientificamente”, in quanto, le
epigrafi “occupano” un arco di tempo che va dal secolo VI a.C. al
1.000 d.C., cioè, fino all’arrivo dei Normanni(!)… I testi di queste importantissime epigrafi, composti in esametri e pentametri
in lingua greca, costituiscono, secondo
l’illustre studioso reggino, Prof. Franco Mosino, “una straordinaria
testimonianza per la storia linguistica e culturale di Reggio e della sua “Chòra”;
inoltre, egli fa notare che da queste “attestazioni”, emerge altresì, che
a Rhègion, “si parlava greco e latino secondo la metrica
greca”.
Dopo il piccolo contributo, di cui sopra, alla tesi “rohlfsiana”, ci piace ricordare
che, da vivo, il grande glottologo e filologo tedesco, ricevette onori e riconoscimenti
nella Calabria tutta: la cittadinanza onoraria di Bova, la laurea “honoris
causa” dell’Università di Cosenza; molti
Comuni, dopo la morte, gli intitolarono vie e piazze, come di recente il paese
di Badolato (CZ).
Tornando alla parte più propriamente
“storica”, possiamo affermare, quindi, l’ininterrotta presenza della lingua
greca durante l’intero periodo “romano” e la nettamente sua maggior diffusione,
specie nella parte meridionale della Calabria, dopo la caduta dell’Impero,
anzi, essa rappresentò anche la “varietà alta” fino all’XI sec., ovvero, fino
all’avvento dei Normanni, i quali diedero avvio – con l’appoggio della Chiesa
di Roma – ad una irreversibile inversione di tendenza: linguistica, culturale e
religiosa. Gli “uomini del Nord”, infatti, quantunque “nati” predoni e
mercenari, si dimostrarono, strada facendo, conquistatori attenti e dotati di
uno spiccato senso dell’opportunità politica, e, pur apparendo tolleranti nei confronti della chiesa
greca, iniziarono contemporaneamente quell’inarrestabile processo di
“latinizzazione” della Calabria meridionale, che avrebbe condotto, più tardi,
alla fine del rito greco e, quindi, anche del prestigio della lingua greca.
L’anno 1059 (caduta di Reggio) e l’anno 1081 (caduta di Bari), ad opera dei
Normanni, rappresentano due date storiche molto negative, anzi, “cruciali” per
il “destino” della grecità in terra meridionale. Le “buie notti” angioine,
aragonesi e spagnole, più tardi, sono una perentoria conferma della quasi
totale “occidentalizzazione” di usi, costumi, cultura, lingua e religione.
Anche nella Bovesìa, ultimo baluardo greco, dal punto di vista linguistico, culturale e cultuale, la
situazione, già compromessa, sarebbe precipitata dopo la fine (leggi pure:
soppressione) del rito greco-bizantino, nel 1572/73, ad opera del vescovo
armeno-cipriota Giulio Stauriano.
Sull’onda della Controriforma tridentina, al vescovo di Reggio, Annibale
D’Afflitto, basteranno pochi decenni (1593-1638), per sradicare completamente
il rito greco dalle sue ultime ed ormai umilissime “dimore” intorno a Bova e
nelle “Cinque Terre” (diocesi “greca” di Reggio), per trapiantarvi quello
latino.
Da questa epoca in avanti, nella
“Bovesìa e dintorni”, da lingua di culto e di prestigio, il greco passa a lingua della “misera plebs”. Nel 1806, dopo
una fase piuttosto oscura (anche se la lingua greca trova “ospitalità” – ma in
“caratteri” latini – nelle opere del De
Marco, del Mesiani, del Rodotà), l’interesse per il greco di Calabria si
riaccese dopo che J.C. Eustace visitò la zona sud-aspromontana e segnalò
“popolazioni di lingua greca” e, più
ancora, dopo la pubblicazione sul “Philologus”, di alcuni canti “bovesi”
di Karl Witte (1821), commentati qualche decennio più tardi dal Pott (1856). Fu
dalla seconda metà dell’800 che cominciò ad aprirsi una profonda discussione
sulla origine e la natura di questo “greco-linguaggio”. In particolare (come
accennato in precedenza), Giuseppe Morosi (1870-1878), sosteneva l’origine
bizantina dell’idioma greco parlato in questi territori e fu una teoria che fino
al 1924 imperò incontrastata fino a quando, il più grande filologo, glottologo
e dialettologo della storia, l’illustrissimo Prof. G. Rohlfs, non la “demolì”,
in modo scientifico. L’illustrissimo studioso tedesco, a cui la Calabria (e non
solo) deve moltissimo, produsse un
fondamentale “corpus probatorio”, di ordine lessicale,
morfosintattico, onomastico, toponomastico, fitonomastico, agionomastico, ecc.,
raccolto dal 1921 al 1980 circa, anche attraverso visite “porta a porta”, di
350 località in Calabria, spesso a
“dorso di mulo”, con il quale fu in grado di fornire, inequivocabilmente, la
prova della ininterrotta presenza del greco “ex temporibus antiquis”.
Ma, parallelamente al crescente
interesse degli studiosi per la lingua greco-calabra, si imponeva, specie dalla
fase immediatamente successiva all'Unità d’Italia, la necessità di imparare la
lingua italiana e di adoperarla non più soltanto per iscritto; presso le classi
colte e quelle borghesi, l’esclusione
dagli usi familiari delle varietà dialettali veniva concepito come un
passo necessario per il buon apprendimento della “lingua della Nazione”. Lo
stesso dovette avvenire nella attuale “Isola Ellenòfona”, rispetto non tanto al
dialetto romanzo ma al greco, la varietà più stigmatizzata e percepita lontana
dall’ italiano, il cui utilizzo – anche in famiglia – avrebbe solo avuto
l’effetto di “inficiare” una adeguata competenza della lingua nazionale. La
scolarizzazione obbligatoria, faceva subire alle masse contadine monolingui
(parlanti il greco) dell’area, quotidiane umiliazioni e severe punizioni
derivanti soprattutto dall’alloglossia più che dall’analfabetismo. Per cui, ben
presto, la “dicotomia”: proletariato grecofono analfabeta/borghesia italofona
alfabetizzata, scatena il “meccanismo” della discriminazione e della
“tabuizzazione” del greco… All’opera di “demolizione” della lingua greca,
pertanto, non sono estranee cause di natura psicologica, in quanto, viene “pilotato” dall’alto il concetto che tutto
ciò che non è cultura nazionale in lingua, è sottocultura, “avanzo ancestrale”…
concetto, che viene interiorizzato dai “grecofoni” che ormai “percepiscono” il
loro idioma e la loro (quantunque, plurimillenaria) cultura, come espressioni
di inferiorità di razza e di civiltà (!)… di cui bisogna “liberarsi” cercando
altre identità… (“Sic transit gloria mundi”, mi verrebbe da dire…).
Inoltre, le comunità dell’Area Grecanica
(e non solo), vengono “investite” da un saldo migratorio rilevante, che diventa
critico, a ridosso degli anni ’50, ’60 e ’70, derivante, soprattutto, dallo
svuotamento delle aree collinari e montane, in cui, tradizionalmente, erano
insediate le popolazioni ellenofone. Come se, in un certo senso, la scoperta di
un mondo “nuovo” (Italia, Europa, Americhe, ecc.), diventa, contemporaneamente,
la quasi fine di questo “vecchio” mondo, quello dei Greci di Calabria.
A ciò, si aggiungono le alluvioni
che si succedono negli anni ’50 e ’70 nell’enclave greca e che compromettono la
sopravvivenza “materiale” delle comunità nell’entroterra pre-aspromontano, con
“l’ineludibile effetto” di giungere all’impoverimento, alla “deplezione” della
memoria, il cui “trend negativo”, rischia di cancellare completamente
tradizioni e lingua… A tal proposito, il linguista olandese Dimmendaal,
sottolinea quanto sia di vitale importanza per la lingua, rimanere “in situ”,
sostenendo che, “i cambiamenti nell’assetto economico e sociale delle comunità
alloglotte, possono non essere decisivi nella “sostituzione linguistica”, se la
popolazione o una parte di essa rimane “in situ” (l’esempio di Bova-Chòra,
nello specifico, è assolutamente “probatorio”).
Secondo un’indagine effettuata
sul campo, alla fine degli anni ’90, in seno alla quale vennero interessati
circa 300 studenti delle scuole medie ed elementari della Bovesìa, è emerso che
il “greco di Calabria”, viene considerato “lingua dei vecchi” e non “intriga”
le giovani generazioni che, in generale,
non lo parlano pur comprendendolo passivamente per un 15% circa. La
risposta, però, quasi plebiscitaria dei ragazzi all’item: “ti dispiace che il
greco di Calabria stia scomparendo?” (con…
l’88% di risposte affermative), deve essere “tesaurizzata” da chi ha a
cuore le sorti di un patrimonio così importante da rappresentare un bene
immateriale unico…
Oggi, con un ritardo di oltre 50
anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana – il cui Art.6 “tutela,
con apposite norme le Minoranze Linguistiche” – abbiamo finalmente una Legge
Nazionale, la n. 482 del 15 Dicembre 1999, nonché, la Legge Regionale 15/03 (con
le sue “appendici”), ed il D.P.R. 345/01. Ma, qual è lo stato attuale della
lingua greco-calabra nell’Area Grecanica? Quali sono i “limiti” ed i territori
ammessi a tutela? E quali veramente ellenofoni? Amministrativamente, l’Area
Grecanica comprende 16 Comuni che da Reggio e Cardeto si “spalmano”, da
occidente ad oriente, nella fascia pre-aspromontana e nella costa ionica fino
al Comune di Samo. Questa organizzazione
politico-amministrativa non rispecchia, comunque, quelli che sono gli effettivi
“confini linguistici”, per cui bisogna distinguere i territori dove ancora
persiste l’antico idioma, da quelli in cui l’ellenofonia è pressoché estinta,
“specificando” che esiste una “Area Culturale Grecanica”, che ha nel suo
“cuore”, quel “diamante incastonato” che è l’Isola Ellenofona o Grecofona, testimonianza vivente di un
mondo linguistico che è stato per secoli e secoli, “denominatore comune” non
solo dell’attuale Area Grecanica ma di gran parte dell’intera Calabria. Questi Comuni “ellenofoni” sono:
Bova, Bova Marina, Condofuri (con Gallicianò), Roghudi e Roccaforte del Greco:
piccoli paesi in cui oggi, più che mai, è importante riscoprirne le “radici”
che svelano, anche ad un visitatore un po’ distratto, il carattere che rende
unica questa terra: la “grecità”! “Rize”, spesso trascurate dalle poche
“memorie di carta” di questa terra, ma che è necessario salvaguardare affinché
si ponga un argine e si arresti la “diaspora”, la “emorragia”, l’abbandono
dell’entroterra, con il favorire la permanenza, in questi siti, dei “parlanti”,
delle loro famiglie e dei loro concittadini. Si può dire che Bova, e – con
encomiabile sforzo – anche Gallicianò, siano stati in tal senso, antesignani, in
quanto hanno scommesso sulla antica lingua e cultura dei Padri (“in loco”),
riuscendo, così facendo, anche a valorizzare in maniera esemplare, emblematica,
quelli che sono considerati, a ragione, due fra i “Borghi più belli d’Italia”.
Ed andiamo ad affrontare, ora, il
“nocciolo del problema, ovvero, la “obbligatorietà dell’insegnamento” nelle
scuole dell’obbligo. L’auspicio è che il Legislatore Regionale possa modificare
il dettato legislativo, trasformando l‘insegnamento della “lingua di minoranza”,
da “servizio a richiesta”, in obbligo scolastico, in modo che concorra, a pieno
titolo, alla “formazione” dei ragazzi. L’Area Grecanica, quantunque, in un
tempo passato (ma non trapassato), territorio “monolingue” (greco), non è allo
stato attuale – realisticamente – un territorio bilingue, come quello
altoatesino, valdostano o friulano (le cosiddette “minoranze frontaliere”), in
quanto, se si fa eccezione per una ridotta minoranza di “locutori” (per
fortuna, in evidente “crescita” – quantunque “scolastica” – in alcuni paesi), appare lapalissiano, che la speranza
della sopravvivenza della lingua greca di Calabria sia riposta soprattutto
nella scuola. È auspicabile che le istituzioni scolastiche della Provincia,
ricadenti nell’Area Grecanica, facciano però il loro dovere e consentano l’applicazione – attraverso i Progetti –
delle norme di legge (finora sostanzialmente disattese), ed attivino – in
attesa dell’auspicata obbligatorietà – corsi di insegnamento, anche
extra-curriculari, che, a partire dalle scuole materne accompagnino i ragazzi
fino ad almeno le scuole medie. Se applicate, le leggi 482/99 e 15/03 (oltre al
D.P.R. 345/01), contengono già norme specifiche per l’insegnamento delle lingue
minoritarie nelle scuole delle comunità linguistiche “riconosciute”. Si
tratterebbe, in definitiva, di riconoscere il diritto degli appartenenti a tali
minoranze ad “apprendere’’ la propria lingua-madre (o, forse, di…
“riappropriarsi” di essa). Bisogna confidare,
altresì, in una maggiore sensibilità e senso di appartenenza anche da
parte degli stessi dirigenti scolastici. E che le stesse Università facciano la
loro parte attivando – “ope legis” – corsi di lingua in via sperimentale.
In conclusione, non si può non
rimanere in attesa di una effettiva applicazione delle leggi di tutela già esistenti, e, ancor meglio, del più che
auspicabile insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado,
altrimenti – nonostante gli sforzi compiuti in questi ultimi anni, dalla
Provincia di Reggio Calabria e dalle numerose Associazioni Culturali Ellenofone
presenti nel territorio – le lingue minoritarie, non “frontaliere”, sebbene,
fondamentali segmenti di antichissime
culture, corrono concretamente il malaugurato rischio di scomparire
completamente nel giro di qualche decennio…
In definitiva, però, il
“patrimonio genetico” di una cultura plurimillenaria, che conserva tratti di
preziosa rarità, e, addirittura, di assoluta unicità, non si può pensare di
riuscire a salvaguardarlo ed a rivalutarlo solo con l’applicazione di leggi di
tutela, ma, deve essere “in primis”, un vivo interesse del cuore, una
appartenenza consapevolmente vissuta… La tutela della memoria storica, per
quanto poco “cartacea”, può giocare un ruolo primario, se vissuta, non in termini
“nostalgici” (“Io dico memoria, passato, nel senso di riappropriazione e non di
pura nostalgia…”).
Anche per questo, e per amor del
vero, va riscritta la storia dei Greci di Calabria, in quanto quella (poca) già
scritta, si presenta come una “storia negata”… Sarebbe necessario promuovere
una “nuova stagione” di contributi storiografici, condotti deontologicamente e
nella direzione della formazione di una corretta coscienza storica.
La lacunosa conoscenza del
proprio percorso storico da parte dei “Grèki tis Kalavrìa”, unita alla
sensibilità ancora scarsa da parte di Enti ed Istituzioni (come già accennato),
costituiscono tutt’ora ulteriori ostacoli per la valorizzazione dell’importante
patrimonio storico-linguistico-culturale-religioso del territorio greco-calabro.
Per fortuna, le Associazioni Ellenofone – ribadiamo – hanno avuto un ruolo
fondamentale, quasi da “supplenza istituzionale” nell’ambito, soprattutto,
della difesa del patrimonio immateriale, caratterizzato da una tale
peculiarità, da indurre la Regione Calabria (con il sostegno delle Provincia di
Reggio Calabria e delle altre Province calabresi) a far approntare un dossier
per una ambiziosa candidatura Unesco – delle Minoranze Linguistiche Calabresi –
come Patrimonio dell’Umanità.
Mi sia consentito, infine, di
stigmatizzare quegli “sporadici rigurgiti di campanile”, di qualche singolo “ellenofono”
(o, pseudo-tale), che non giovano – in quanto tese più a dividere che ad unire
– alle comunità “greche di Calabria”, che invece hanno bisogno di coesione per
alimentare assieme e cementare il comune, granitico “spirito greco”, vivendo
fino in fondo l’emozionante privilegio di essere (senza, per questo, voler
stabilire “gerarchie culturali” che non esistono...), i legittimi eredi di quella cultura che è stata l’elemento
fondante della civiltà occidentale e di quella antichissima “glossa”, per
secoli, “lingua del cuore” di gran parte delle popolazioni del Meridione, e che
le inossidabili comunità grecofone della Bovesìa hanno ancora l’onore di condividere
e di esserne suoi orgogliosi e gelosi
custodi…